Mumbai, Elastable, Sogno Borghese Flessibile, Lapidea.
Sono solo alcuni nomi scelti dall’architetto e ceramista Gaetano di Gregorio per la sua produzione di ceramiche. Titoli per serie di oggetti esposti un po’ in tutto il mondo (Stati Uniti, Brasile, Germania, Francia, Finlandia) che introducono a una riflessione profonda su simboli, linguaggi, materia, forma. Sul processo e il metodo di lavoro del designer, sui valori culturali ed ecologici che lo ispirano; l’ambiente, il territorio.
Quasi a sottolineare e indagare quell’inevitabile rapporto ludico e misterioso che abbiamo con gli oggetti e la casa l’architetto osserva:
“ Mi piace pensare che la casa non possa soddisfare le aspettative di chi le abita e che ci sia sempre, da parte nostra, un’attenzione derivante da qualcosa di incompiuto, perfettibile, che porta a desiderare, a progettare e immaginare soluzioni sempre diverse” .

Gaetano di Gregorio è nato a Catania, vive e lavora a Venezia, dove ha fondato Spiazzi un centro indipendente per le arti visive e il design che promuove il design autoprodotto. Un tema, quello dell’autoproduzione, del potenziamento della visibilità di artisti e designer affrontato anche da Michela Codutti di Euroinnovators
D_Architetto, ceramista, designer. Esiste una linea di confine fra questi tre ambiti creativi ?
R_ Anche se apparentemente diversi, affronto questi tre ambiti con la stessa attitudine, quella del progettista. Non sono un istintivo, non faccio ricorso a un supposto talento. Qualsiasi cosa affronto viene sempre prima esplorata da un pensiero progettuale.
L’architettura e il design si somigliano molto, spesso vanno a braccetto, soprattutto nel progetto di interni. Nella ceramica, invece, plasmare l’argilla con le mani può non richiedere troppe riflessioni e rimane un gesto istintivo. Ma anche qui, non riesco a fare diversamente.

In Cina, in una residenza d’artista presso il Sanbao Institute di Jingdezhen, un ceramista olandese vedendomi lavorare mi chiese se fossi un architetto. Lui realizzava al tornio vasi bellissimi, io invece preparavo sfoglie di argilla che tagliavo e assemblavo con un disegno a fianco. Si sarà chiesto perché mai fossi lì, in mezzo ad altri ceramisti.
Ognuno di questi tre ambiti ha comunque le sue diversità: la scala, i tempi, le maestranze coinvolte. Ci sono linee di confine, che però sono aspetti materiali, non di processo o attitudine. Mi piace il fatto che quando si presenta un problema in architettura, io possa distrarmi passando a quelli della ceramica, e così via.

D_Dal macro, architettura e interni, al micro, con le tue serie di oggetti. Quale la tua filosofia di progetto?
R_ Se c’è un filo conduttore in tutti i miei progetti è quello di pensare all’ambiente e al territorio, ai suoi valori ecologici e culturali, sia nella larga scala del paesaggio, sia in termini di materiali o soluzioni sostenibili per gli oggetti che progetto e realizzo.

L’attenzione all’ambiente che tento di esprimere anche nel processo produttivo mi aiuta ad alimentare una narrazione. Sono per generazione figlio di una cultura che andava dal “cucchiaio alla città” quella dell’architetto demiurgo che, talvolta, nel passaggio di scala, prendeva qualche cantonata.
Ricordo la reazione di Italo Lupi, all’epoca direttore responsabile di Abitare, a un mio tavolo progettato e realizzato come supporto per le ceramiche, esposto al Salone Satellite. Un tavolo assemblato velocemente, in un ex capannone militare con tetto di lamiere sorretto da capriate poverissime e tavole appaiate. Quella soluzione pratica e povera del tetto mi aveva ispirato la realizzazione del tavolo composto di cavalletti, tenuti insieme al piano da fasce di caucciù.
Italo Lupi mi chiese se fossi uno studente di architettura o design, perché leggeva in quel tavolo un riferimento strutturale inequivocabile, che solo un architetto può concepire; commentando che gli architetti, pure nei loro corsi di studi confusi, e fin troppo inclusivi, hanno un senso estensivo del progetto che deriva dalla complessità della loro formazione e dalla varietà delle loro esperienze. Quel tavolo è diventato Elastable, un tavolo modulare.

Un altro tema che mi piace molto perseguire è l’approdo a soluzioni che implicano il minimo uso di materiale e di energia, così come quando cucino, cercando di raggiungere il massimo del gusto con il minimo uso di grassi o di ingredienti facili come il burro. Ma qui si apre un altro discorso che non è il caso di affrontare ora.Tornando al progetto, lo sforzo che metto in campo è sempre quello di utilizzare, o se possibile, riutilizzare il materiale, praticando una modalità in cui la bellezza è conferita dal pensiero che è intervenuto per realizzare il prodotto, e non il materiale in sé.
Non provo interesse per materiali ricchi, preziosi, importanti. Non fanno per me. Mi piace tutto ciò che è povero e può esprimere qualità se ben utilizzato. Se possibile, anzi, faccio lo sforzo di conseguire, a ritroso, soluzioni basiche, quasi primitive.
D_ Con la serie Lapidea sposti il modo di guardare la ceramica “Appena sotto la superficie”. Come nasce questo progetto?

R_ La serie che per semplicità chiamo Lapidea, richiama un mondo minerale, riporta l’argilla alla sua matrice geologica, nasce da lontano, ed è forse un condensato della mia esperienza.
Con questo materiale ho iniziato a lavorare poco più che bambino nelle botteghe di Caltagirone. Dopo aver esplorato per diversi anni la ceramica come materiale che si forma, compiuta e oggetto. La maturità sviluppata mi ha portato a riflettere sull’ argilla, facendo un passo indietro, cercando cioè di capire come e cosa potesse esprimere il materiale di base.
Come se un pittore sospendesse l’attenzione su ciò che rappresenta nei suoi quadri e si mettesse a ragionare sui colori, sulla loro composizione, sulla loro natura.
A quel punto la forma non è stata più l’oggetto della mia ricerca progettuale, ma ha preso il sopravvento l’interesse per la materia. Attorno all’argilla ho costruito una riflessione che mi ha portato a considerare la possibilità di utilizzarne diverse per colore e composizione. Mimando ciò che avviene in natura, quando si formano le pietre, per sedimentazione di strato su strato, in un processo lunghissimo, che racconta le ere geologiche, i cataclismi, i depositi di fango con colori diversi, striature, inclusioni, persino conchiglie.

Tutto questo mondo intrappolato nelle pietre, nel volume delle pietre si può vedere soltanto quando la materia viene tagliata o levigata. Il procedimento che io ricreo artificialmente non è altro che una riproduzione in laboratorio di materiale lapideo, includendo nell’impasto pezzi di argille diverse, che emergono nella forma e nel colore finali solo quando il pezzo viene levigato o tagliato, mostrando appunto il suo interno.

Di solito il valore della ceramica coincide con la sua superficie che può essere smaltata, graffiata, lasciata al grezzo, incisa. Nessuno è interessato alla parte interna.
Invece con questo processo si può rilevare un mondo interessante che richiama il terrazzo alla veneziana, la graniglia, la palladiana, che appunto si mostrano nel momento in cui vengono levigate. Togliere uno strato e passare al volume è il lavoro che rinnova ogni volta lo stupore di vedere cosa emerge, quali geometrie e quali colori.Essendo Lapidea un lavoro sul materiale, anzi, essendo un materiale interamente composto di argilla, è venuto naturale pensare alla varietà di applicazioni che può consentire.

Dopo una serie di test ho potuto appurare che il materiale si presta ad essere lavorato sia manualmente, per realizzare manufatti come vasi o accessori , sia in maniera più industriale per compressione e sfogliatura, per realizzare superfici o elementi per l’edilizia.
Lapidea infatti è un materiale che ricorda la pietra, pur non mimandola, ha la resistenza del grès che consente lavorazioni più sostenibili perché non prevede spreco, anzi, il totale recupero del materiale di lavorazione.
Lapidea si pone come un progetto aperto che si presta a diverse declinazioni e sperimentazioni sia sulle texture, le composizioni, sia sulle possibilità applicative. Un lavoro che è un prodotto ma anche un processo. Forse, il progetto più completo che finora abbia realizzato.
 D_ Tulipiere fa pensare a un gioco di funzione e “finzione”. La decorazione che solitamente in questi vasi è esterna, la tua tulipiere la nasconde all’interno. Ribaltato è il ruolo della materia ricondotta pura e grezza all’esterno.
D_ Tulipiere fa pensare a un gioco di funzione e “finzione”. La decorazione che solitamente in questi vasi è esterna, la tua tulipiere la nasconde all’interno. Ribaltato è il ruolo della materia ricondotta pura e grezza all’esterno.
R_ Il vaso Tulipiere è un lavoro che condensa più culture e paesaggi. La forma magmatica e pulsante conduce alla mia matrice mediterranea, agli orci di Caltagirone, alle rotondità delle grandi madri, al colore stesso della lava dell’Etna.

La funzione richiama il mondo nordico, al capriccio di un vaso realizzato solo per il tulipano, fiore cha ha bisogno di spazio per distendere le sue foglie ricurve e che occupa un foro intero. La decorazione viene invece dalle decalcomanie cinesi, delicati fiori di ciliegio, azzurri, che occupano però la parte interna, quasi a voler sottolineare che la parte più preziosa va cercata, e forse anche protetta.
Il vaso esprime un rovesciamento, mostra la parte grezza e terrosa e lascia intravedere un’anima ricca, solenne, ma solo per chi sa guardare. Come dire che la bellezza più autentica è soprattutto un fatto interiore.
D_ Teapots è un progetto di design al confine con l’artigianato. Qui unisci ceramica, feltro, neoprene.
R_ Se esiste un confine fra arte e artigianato a me piace attraversarlo, portando qualcosa dell’una nell’altro. Queste teiere nascono dopo il mio primo viaggio in Cina, dove osservavo la modalità estremamente precisa di lavorare la porcellana. Il fatto che quasi tutto dovesse avere una funzione mi aveva ispirato qualcosa che fosse utilizzabile, ma anche sperimentale.

Ho pensato a queste teiere che sono una piccola indagine sui concetti di caldo/freddo, duro/morbido. Associano alla ceramica tradizionale materiali che favoriscono la presa e consentono di non scottarsi, come il feltro ed il neoprene, che hanno inoltre proprietà isolanti, quindi contribuiscono a tenere caldo il the.

Questo tema non poteva a mio avviso adattarsi alle forme consuete. Mi è sembrato naturale attribuire una forma del tutto nuova, che a prima vista non ricordasse una teiera, ma si legasse a un diverso modo di prendere e versare il the. La forma ispira un concetto di ritualità, di cerimoniale, il tempo che una persona dedica a se stessa. Forse non una teiera da usare tutti i giorni, ma un oggetto che possa assecondare un rito, una gestualità, svincolata dalla fretta.
D_ Mumbai è interamente fatto a mano, quasi a sfidare le regole della produzione e lo stesso ruolo del designer. Com’è cambiato il ruolo del designer? Quale la direzione oggi?
R_ Il processo che ho avviato con Mumbai, un vassoio da the, esplora le possibilità di realizzare a mano un prodotto che riduce al massimo l’apporto tecnologico e razionalizza l’intervento manuale.

Il proposito consente un duplice vantaggio: il primo è quello di rendere il designer totalmente indipendente nella realizzazione. Il secondo è di ottenere un prodotto contemporaneo che porta con sé il valore del fatto a mano, proprio come un oggetto artigianale.
Con la separazione dei ruoli, l’artigiano è diventato un terzista che esegue il progetto del designer che si limita a progettare senza prendere parte alla realizzazione.
In questo caso ho voluto dare spazio ad un’attitudine più pratica, da designer operaio che si sporca le mani realizzando ogni singolo pezzo, assumendo un maggior controllo del suo lavoro.

In generale una parte del design si sta spostando già da anni verso una dimensione più artigianale sospesa fra design, arte e pezzi unici da collezione. Trovo molto interessante e stimolante questa virata che offre più spazi e sfumature in cui le diversità sensibili possono esprimersi. Oggi, convive la dimensione seriale del prodotto industriale a quella più autoriale, accontentando gusti di più clienti e assecondando diverse attitudini dei designer, che in alcuni casi si fanno anche realizzatori del prodotto.Le nuove tecnologie consentono l’attuarsi di questo processo attraverso stampanti 3d e macchine di controllo numerico, che rendono possibile quasi ogni progetto.
D_ Le grandi catene low cost, Zara Home e Ikea hanno introdotto nuovi concept di interior meno omologanti e massivi. Cosa ne pensi?
R_ Penso che le grandi catene abbiano un costante bisogno di avvicinarsi al cliente e dimostrare che il prodotto industriale – che ha l’indubbio vantaggio di essere economico – se ben presentato, può rivelarsi meno impersonale.
Queste operazioni consentono di rivedere alcuni schemi e aiutano le aziende a fornire soluzioni più personalizzate, anche solo come suggestione.
Talvolta le grandi catene affiancano alle produzioni massive anche capsule collection, piccole edizioni limitate di grande appeal perché disegnate da nomi importanti. Trovo che sia una strategia di marketing per nulla criticabile, che non contraddice il prodotto industriale, anzi lo celebra, lo vivifica.
Dopo anni di minimalismo e privazione, il mondo del design sembra voglia abbracciare lo spirito ironico e ludico degli anni Ottanta, forse per nostalgia di quei tempi in cui tutto è esploso. Forse per tentare di esorcizzare questi tempi così incerti e difficili, si insegue la leggerezza. Penso che sia sempre benvenuto un design che sappia maneggiare aspetti simbolici, bellezza e colori, che stupisca e lo faccia con maestria.
D_ Con le teste di moro a forma di doge veneziano, rievochi la sapienza degli artigiani di Caltagirone, il loro significato, l’immaginario, il racconto. Quanto è importante per te stabilire connessioni tra culture? Ci parli del progetto Dehua Tales?
R_ Le teste sono un omaggio a Caltagirone, la città da cui provengo, e a Venezia, la città dove vivo e lavoro. Le tradizionali teste di moro, la cui storia affonda le radici nella Sicilia della dominazione araba, sono da me state trasformate in teste di doge, la figura mitica della Repubblica Serenissima.

Un vaso antropomorfo, un oggetto antico di proto design che racconta di storie legate al Mediterraneo, realizzato dalle maestranze di Caltagirone con tecniche tradizionali, caricato di un significato nuovo più estensivo, che esprime un po’ di autobiografia tra passato presente, tra Caltagirone e Venezia.
Per me le storie sono importanti. Se un oggetto racconta una storia mi sembra che abbia già un buon punto di partenza. Le porcellane Dehua Tales sono, invece, frutto di un viaggio di lavoro in Cina nel 2015, a Dehua, città del sud-est cinese, dove sono maestri nella lavorazione della porcellana bianca. Una fabbrica aveva messo a disposizione di trenta artisti il loro prodotto e tutto il know how per realizzare in quindici giorni una serie di opere che poi avremmo dovuto esporre.

Eravamo trenta artisti provenienti in parte dalla Cina, altri, dal resto del mondo. Un sogno poter disporre di tali risorse, ma poco tempo per partire da zero con un nuovo progetto.

Conoscendo i tempi di lavorazione della porcellana ho deciso quindi di lavorare plasticamente con i vasi messi a disposizione dall’azienda componendo una famiglia di oggetti che includessero frammenti e cocci degli stessi vasi, incollati con gli smalti in fusione e lavorando sul collo dei vasi stessi.

Un lavoro sul frammento e sul recupero, sulla capacità della materia di esprimere contenuti estetici nuovi, con pochissimi mezzi, usando i cocci come elementi decorativi e gli smalti come collante. Un modo di lavorare che colpì molto il proprietario della fabbrica, definendolo la mia una visione buddista del procedimento, associazione che ancora devo decifrare!
D_ Per lo specchio Sogno Borghese Flessibile hai utilizzato polistirolo specchiante, quasi a sdoganare e nobilitare ironicamente il materiale. Perché questo titolo? Quale il messaggio di Your Own Personal Jesus? E di Climbing in the Mirror?
R_ Mi affascinano da sempre i materiali e spesso gli usi non convenzionali degli stessi. Alcuni colleghi che lavorano nel cinema mi hanno sottoposto questo materiale specchiante e flessibile che ho trovato carico di possibilità. Perché non valorizzare uno specchio veneziano?

Possedere pezzi di antiquariato rientra nel sogno borghese, ma questi specchi che richiamano forme classiche tagliati al laser sono un sogno borghese più flessibile, considerata la precarietà di tante nostre esistenze, che un antiquario non sa neanche cosa sia.
Un sogno borghese flessibile che possiamo incollare ovunque, anche sul frigo, che si adatta a diverse superfici e riflette i nostri visi talvolta deformandoli, come talvolta deforme appare il nostro tempo. Personal Jesus è un crocifisso. Anche in queso caso l’intento è di semplificare i segni, attutire il senso di sofferenza, includere simboli di altri religioni, provare a dimostrare che nonostante le culture siano diverse, la matrice è comune.
La cultura è una delle differenze e per quanto importanti, le differenze non possono e non devono essere un ostacolo. Personal Jesus è un crocifisso provocatorio, pensato per le scuole nel momento in cui la discussione era accesa. Sono sempre stato attratto dai simboli e penso che l’iconografia religiosa, su cui tanto hanno lavorato gli artisti del passato, possa essere campo di sperimentazione interessante, ancora troppo poco esplorato: per questo crocifisso ho usato l’acciaio supermirror, un materiale leggero, prezioso, senza essere inaccessibile. La figura di Cristo resa un pittogramma, riflette l’uomo che si guarda allo specchio.
OJI Climbing the Mirror è invece un dispositivo modulare che è allo stesso tempo uno specchio e un appendiabiti. L’ispirazione interamente rivisitata e contraddetta è quella delle specchiere da ingresso con appendiabiti: un oggetto familiare che accoglieva gli ospiti nelle case di qualche anno fa. Stesse funzioni, ma forme diverse, grazie ai materiali che consentono grande flessibilità in un’ottica di oggetto modulare on demand realizzato sulla base delle esigenze che esce da un visione del prodotto di massa.
D_ Delle tue Bird House hai detto: “Questa casa è per gli uomini ma può piacere tanto anche agli uccelli. Anche se nessuna casa saprà mai soddisfare le aspettative di ciascuno”. Quale il cambiamento in atto nella casa e nell’interior? Si può parlare di una casa post pandemia?
R_ Le Bird House sono un gioco, una metafora della casa degli uomini. Un’occasione per sperimentare soluzioni grafiche, ironiche e riflettere sul senso che ha la casa per l’uomo.

Nessuna casa potrà mai soddisfare le esigenze di ciascuno, ed è un cosa che penso profondamente. Anche il miglior progetto di interior è qualcosa che alla fine si cristallizza e non riflette i tempi che cambiano, le esigenze che mutano.
Forse la casa dovrebbe essere sempre in trasformazione e allo stesso tempo contenere punti di riferimento che ci rendano saldamente ancorati a terra, ricordi, mobili di famiglia. Della mia casa in campagna salverei solo una credenza in castagno che da circa un secolo accompagna le vicende della mia famiglia. L’unico mobile senza il quale la casa non sarebbe più tale. Tutto il resto potrebbe cambiare.
Mi piace il fatto che la casa non possa soddisfare le aspettative di chi le abita e che ci sia sempre un attenzione derivante da qualcosa di incompiuto, perfettibile, che porta a desiderare, a progettare e a immaginare soluzioni sempre diverse.
Tutto questo a maggior ragione in una casa sovvertita dalle nuove abitudini indotte dalla pandemia, che hanno fatto rimpiangere la privacy degli ambienti, un giardino, un terrazzo; che ha fatto scoprire che si può passare più tempo in casa e che c’è bisogno di spazi flessibili, di luoghi dove concentrarsi e lavorare, di soluzioni pratiche, efficaci e non per questo meno belle. La pandemia è stata un’occasione molto interessante sotto il profilo della progettuaità di spazi e arredi. Io stesso mi sono misurato con la progettazione di un tavolo che consente di avere privacy e uno sfondo neutro per le videocall, che tanto caratterizzano i nostri momenti lavorativi.
Ancora adesso mi sorprende vedere sfondi domestici così inadeguati, nei mesi di lockdown proiettati senza pudore in tv, nel web, una cosa che ha reso più umano il circo dei media, fatto di luci perfette e atmosfere artificiali e allo stesso tempo ha sbattuto in prima serata il quadro storto del soggiorno.
Mi piace pensare che la casa, lungi dall’essere una macchina perfetta, possa consentire spazi intermedi, soluzioni che traghettino dall’intimità al mondo iperconnesso, con uno schiocco di dita. Se dovessi scegliere fra le due categorie direi che la casa post pandemica è più protettiva e tecnologica nel senso che è diventata più nido. Le persone hanno sofferto l’isolamento, ma credo anche abbiano scoperto il piacere di vivere la casa, di renderla più accogliente, vissuta, performante, vivibile.
D_ Sei docente di interior design allo IED di Venezia. Quale l’atteggiamento dei giovani designer nei confronti dell’artigianalità, di temi sensibili come la sostenibilità, il riciclo, il recupero?
R_ Si parla tanto dei giovani d’oggi come di una generazione che non sa più cosa vuol dire leggere un libro, totalmente assorbita dalla tecnologia. I miei studenti mi sorprendono, pur essendo figli del proprio tempo, rispetto al tema dell’artigianato, ad esempio, sono sicuramente molto curiosi.
Hanno molto amato i tessuti della manifattura dei tessuti Bevilacqua, di Venezia, che lavora con telai settecenteschi. Le vetrerie di Murano. Si sono confrontati con fabbri, falegnami, comprendendo il valore del lavoro artigianale e della qualità, sia per i loro progetti di studenti o che affronteranno come professionisti.
Rispetto ai temi ambientali sono sicuramente più consapevoli di noi adulti, perché sono cresciuti nel pieno manifestarsi del problema dei cambiamenti climatici.
Molto spesso nei loro progetti si pongono il problema del riciclo, dello scarto, della sostenibilità. In questa confusione, e in questo clima di incertezza per il futuro, il loro approccio mi lascia ben sperare. Sembra abbiano capito come operare e con quali strumenti. Noi eravamo mentalmente più aperti e curiosi con una forte propensione per la critica e la teoria del progetto, mentre loro mi sembrano decisamente più operativi e pragmatici, soprattuto rispetto all‘uso delle risorse. Basta pensare che tutti, in aula, portano la loro borraccia e mai nessuno si è presentato con una bottiglia di plastica.
Gaetano di Gregorio: web site – instagram

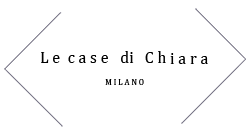 Le Case di Chiara
Le Case di Chiara


